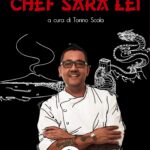Per la prima volta a Roma sono esposte le più significative “Nature morte” della collezione di Geo Poletti (Milano 9 aprile 1926 – Lenno 13 settembre 2012), storico dell’arte, connoisseur, pittore e collezionista, famoso per il suo occhio e giudizio infallibile, che formò la sua raccolta a partire dagli anni Cinquanta del Novecento. Epicentro di questo exihibit è la sede di Galleria Corsini a Roma, dal titolo “L’enigma del reale”. Ritratti e nature morte dalla Collezione Poletti e dalle Gallerie Nazionali Barberini Corsini, a cura di Paola Nicita, fino al 2 febbraio 2020. Le 28 opere in mostra sono accomunate dall’adesione alla “Pittura di Realtà” e al naturalismo caravaggesco, in tutte le sue declinazioni note e per certi versi ancora enigmatiche.
Il percorso espositivo parte dalla “Galleria del Cardinale”, dove è esposto il “Democrito” di Ribera, appartenente alla collezione di Geo Poletti sin dai primi anni Sessanta, e inizialmente interpretato come “Geografo sorridente”. Il dipinto, segnato dall’intensità dell’espressione del filosofo e da una forte aderenza ai valori naturalistici, fu realizzato dal giovane pittore valenzano nella fase del passaggio da Roma a Napoli, tra il 1615 e 1618.
“Democrito”- Jusepe De Ribera
La mostra prosegue nella “Camera verde”, dove la “Maddalena penitente” suscita stupore per la sua ostentata nudità: una ragazza poco spirituale che assume un’espressione terrena, malinconica e uno sguardo perso nel vuoto. Dopo un’intricata storia di attribuzioni, la tela è stata ascritta al contesto spagnolo prossimo a Velázquez.
“Maddalena Penitente”- Maestro.
Accanto alla “Maddalena” anche il “Bacco e il fauno” e il “Fauno con uva e flauto” rimandano al tema della pittura di realtà, qui interpretata con crudo realismo, ai limiti dell’asprezza, con un forte chiaroscuro. Sulle tele, la rappresentazione dell’uva e della vite introducono il tema delle “nature morte”, approfondito nella stessa “Camera Verde” e nell’adiacente “Sala Blu”.
“Bacco e Fauno”- Bartolomeo Manfredi.
La fortuna di questi soggetti è legata al formarsi nel Sei e Settecento delle cosiddette “Gallerie principesche di pittura”, dove erano esposti accanto ai dipinti di carattere storico, alle scene di genere e ai paesaggi. Ne sono un esempio le invenzioni festose del barocco internazionale, i banchetti sontuosi, gli spuntini eleganti, come le “Allegorie delle Stagioni” di Abraham Brueghel (Anversa 1631 – Napoli 1697) e di Christian Berentz (Amburgo 1658 – Roma 1722), esposte nella “Camera Verde”.
Segue la “Sala blu” in cui sono presenti le opere più significative della collezione Poletti, esposte quasi tutte senza cornice, secondo il gusto del collezionista milanese. Si tratta di opere magistrali, in cui le luci e le ombre danno drammaticità agli oggetti, animali vivi e morti, frutti e vegetali, che si stagliano nella penombra con una minuziosità fotografica e una consistenza illusionistica che amplifica il senso dell’attesa, irreale e impossibile se non nella forma perfetta della pittura.
Qui spiccano due importanti nature morte raffiguranti “Vasi di fiori e frutta” attribuite da Geo Poletti allo stesso Caravaggio, messe a confronto con la “Natura morta con tuberosa”, anch’essa di pittore caravaggesco, appartenente alla collezione delle Gallerie Nazionali e solitamente non esposta al pubblico.
“Natura morta tuberosa”- Pittore caravaggesco
A rappresentare le scuole regionali della natura morta italiana troviamo le “Cucine” emiliane, gli esempi veneziani di Bernardo Strozzi, fino al realismo di ispirazione caravaggesca del capolavoro giovanile di Evaristo Baschenis “Natura morta con cesta di mele e piatto di prugne, meloni e pere”. Qui il pittore, considerato da alcuni studiosi il massimo esponente italiano di questo genere, raggiunge una visione lucidissima della realtà.
“Natura morta con cesta di mele e piatto di prugne, meloni e pere”- Evaristo Baschenis.
La mostra si conclude nella “Saletta”, dove sono affiancate per la prima volta insieme le tre versioni del “Pescivendolo che sventra una rana pescatrice” provenienti dalla collezione Poletti, dalle raccolte delle Gallerie Nazionali Barberini Corsini e dal Museo nazionale di Varsavia. Un’occasione imperdibile di vedere riunite le tre tele, restituendo loro il contesto di provenienza e un’inedita lettura, sia sul piano attribuzionistico che su quello storico e iconografico, grazie anche alle indagini diagnostiche effettuate in occasione della mostra. La genesi delle tele rappresenta un vero e proprio enigma su cui vale la pena soffermarsi. Il soggetto, un umile pescatore intento a estrarre le viscere di un pesce, viene qui rappresentato come nobilitato, quasi come in un “ritratto all’eroica”. Stupisce poi come tre mani diverse della stessa epoca si soffermino su un tema tanto raro, che non appartiene al genere della natura morta, bensì a quello della pittura di realtà.
“Pescivendolo”- Pittore napoletano.
Quella delle Galleria Nazionali, attribuita prima al romagnolo Guido Cagnacci e poi al fiorentino Orazio Fidani, è in realtà opera di un pittore napoletano della metà del XVII secolo. Anche le altre due versioni, quella Poletti e quella di Varsavia, sono riconducibili allo stesso ambito culturale e alla stessa epoca.