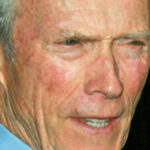Il termine stress fu usato per la prima volta nel 1936 da Hans Selye che lo definì come “risposta aspecifica dell’organismo ad ogni richiesta effettuata su di esso”. Egli sviluppò un modello capace di spiegare come l’organismo reagisce di fronte allo stress, individuando 3 fasi:
- fase di allarme: impiego di risorse per gestire le richieste;
- fase di resistenza: il soggetto stabilizza le sue condizioni e si adatta alle richieste;
- fase di esaurimento: caduta delle difese e successiva comparsa di sintomi fisici, fisiologici ed emotivi.

Questo ci fa intuire come una risposta immediata non causa danni psicofisici, ma una risposta prolungata a condizioni stressanti può causare un crollo psicofisico, caratterizzato da sintomi di vario tipo, quali:
- Sintomi fisici: mal di testa, dolore alla schiena, tachicardia, extrasistole, insonnia;
- Sintomi emotivi: nervosismo, ansia, agitazione, crisi di pianto;
- Sintomi comportamentali: bruxismo,fame nervoso, abuso di sostanze;
- Sintomi cognitivi: difficoltà a prendere le decisioni, preoccupazione, difficoltà di memoria e concentrazione.
Tutti questi sintomi possono portare all’insorgenza di vere e proprie psicopatologie, quali il disturbo acuto da stress, il disturbo post-traumatico da stress, i disturbi ansiosi e dell’umore. Gli esiti negativi dello stress rientrano nel termine Distress. Però dalla definizione di Seyle intuiamo che lo stress non è solo qualcosa di negativo, ma anche adattivo, e gli aspetti positivi dello stress sono definiti Eustress, come ad esempio la soddisfazione di aver superato un evento stressante.
Come gestire le situazioni stressanti?
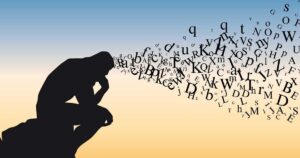
- una valutazione primaria: legata alla percezione dell’evento stressante;
- una valutazione secondaria: legata alle proprie capacità di gestire la situazione.
- Strategie centrate sulle emozioni: cercare di individuare i pensieri irrazionali che alimentano l’ansia e razionalizzarli, utilizzando anche esercizi di rilassamento.
- Strategie centrate sull’evitamento: ignorare l’evento stressante distogliendo l’attenzione dal problema negando sia il problema che le emozioni.
- Strategie centrate sul problema: cercare di analizzare la situazione da tutti i punti di vista, per essere preparati a tutto. Alcuni aspetti di un problema ci consentono un minimo di controllo, come ad esempio un esame. So che se non sono preparato andrà male, ma anche che posso essere preparatissimo ma se il professore ha la luna storta può bocciarmi. Dunque, l’unica cosa che posso fare, l’unica cosa sotto il mio controllo è studiare e prepararsi a qualsiasi evenienza.
Oltre a queste strategie ci sono anche delle caratteristiche personali che aiutano nella gestione dello stress. Per esempio la resilienza, cioè la capacità di uscire da situazioni stressanti in maniera positiva e costruttiva. Anche l’autoefficacia percepita, intesa come la consapevolezza delle proprie capacità, aiuta nel fronteggiare le situazioni stressanti. Se mi ripeto tutto il giorno che sono un buono a nulla sarò portato nelle valutazioni sopra citate a vedere lo stimolo eccessivamente minaccioso e/o a credere di non avere le risorse necessarie per fronteggiarlo, invece se ho una buona considerazione di me mi sentirò competente nell’affrontarlo, emi sentirò capace di superare (quasi) tutte le sfide.
-
©Atuttodonna