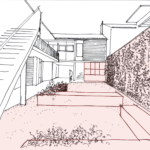Ho fatto un viaggio nel tempo anche oggi. Nel tempo e pure nello spazio, perchè sono in Inghilterra. Ma se non fosse per questa doppia consapevolezza, unita alla conferma dovuta al fatto che qua tutti parlano in inglese, penserei di non essermi spostato di molto da casa.
“Invasione”, “casa loro”, “colonia nera”, sono alcune delle espressioni che sento, incredibilmente, anche a Birmingham, nientemeno che al concerto di Eric Clapton.
E c’è di più, ad un certo punto della serata è il chitarrista stesso a parlare di una colonizzazione nera dell’Inghilterra, invitando i presenti (e siamo tanti) ad appoggiare il leader dell’estrema destra conservatrice e razzista Enoch Powell.
Messe in bocca ad uno dei musicisti di blues che in assoluto preferisco, uno che tra l’altro deve il suo successo alla cover di un pezzo reggae (altra invenzione negrissima) di Bob Marley, queste parole le sento pesanti da digerire. Farlo mi costa di sicuro più fatica di quella che ho speso per accettare, che ne so, una Rita Pavone sovranista.
Ma è il 1976 e l’aria che si respira qui è pesante, ragazzi. Il Regno Unito è scosso da una forte crisi economica, sociale, politica e culturale e l’Inghilterra dei rigurgiti conservatori, in cui sempre più spesso si assiste a violenze a sfondo razziale di gruppi e movimenti fascisti come il National Front, si sta preparando ad eleggere il primo capo di Stato donna nella storia d’Europa, la Lady di ferro Margaret Thatcher.
C’è un altro tratto distintivo però, un elemento che faticherei a trovare se non mi fossi spostato dall’Italia del 2019: è il grande fermento culturale di cui, ovviamente, voglio esplorare il lato musicale.
È Don Letts, un ragazzo di vent’anni di origine giamaicana (i suoi capelli sono acconciati nel tipico stile dei rasta) che sta facendo suonare i dischi al Roxy, nel West End di Londra. Siamo in pieno boom punk e sono circondato da creste, stivali Dr Martin e spille da balia. Don sembra tuttavia a suo agio e, dopo avermi confessato di non essere in possesso di molti dischi di punk, mette su senza alcun problema della roba dub e reggae. Meraviglia delle meraviglie, alle creste si mescolano dei dreadlocks e sia le teste dei rasta giamaicani che quelle bianche e rasate britanniche si mettono ad ondeggiare insieme.
Nella Londra dei punk c’è un altro movimento che sta prendendo piede, il reggae. Le tante band anglocaraibiche che stanno nascendo altro non sono che la faccia nera della stessa medaglia su cui è inciso il volto del punk. Anche i giamaicani di Lodra, come i ragazzi britannici con le creste alte hanno voglia di denunciare la loro condizione di emarginati ed esclusi. “Ci uniamo e ci battiamo per le stesse cose, del resto loro sono esclusi così come noi”, mi spiega Don.
Varie band punk, su tutte i Clash, si stanno aprendo alle influenze reggae e ne propongono brani sia durante i concerti che nelle registrazioni in studio. La benedizione su questa strana fusione di musiche e sulla solidarietà tra comunità arriverà presto da Bob Marley in persona, il messia del reggae, con la sua Punky Reggae Party.
E per chiarire: questa non è solo musica da intrattenimento. Questi ragazzi stanno dando una risposta alle degenerazioni fascistizzanti della crisi ed è una risposta politica, che sarà condensata nello slogan “Rock Against Racism”, la musica è contro il razzismo.
La nascita di generi nuovi è la dimostrazione della possibilità di esistenza di nuovi mondi, basati non su una fredda tolleranza, ma su un abbraccio, una fusione.
Musica spenta, birre, molte, mandate giù. Il risveglio è traumatico e cerco un posto che possa offrirmi una bella colazione all’inglese in grado di tirarmi su. Mentre gli odori forti delle salsicce mischiate ai fagioli e alle uova penetrano violentemente le mie narici, i campanelli legati alla porta d’ingresso del pub tintinnano, fungendo da sveglia definitiva.
Sono due ragazzi a sedersi al tavolo proprio di fronte al mio. Quello che mi dà le spalle ha un tono entusiasta mentre si rivolge all’altro.
“Vedi Gordon, il progressive rock sta morendo. Costa troppo incidere quei dischi elaborati e fare quei tour faraonici. E poi alla gente non interessa più. Ci vuole verità, bisogna tornare all’essenza. In questo il punk ci sta dando una gran lezione”.
“Beh Stewart, io col punk c’entro poco o nulla, mi piace il rock si, mi appassiona il jazz ma non credo che…”
Il ragazzo di spalle lo interrompe con una risata: “Scusa se ti interrompo, ma ho notato che anche l’altra volta indossavi questo maglione a strisce gialle e nere, deve piacerti molto”.
“Si, è il mio preferito. Quando suonavo a Newcastle mi dicevano che mi fa somigliare ad un’ape. Per questo mi chiamano Sting!”




 The Police.
The Police.